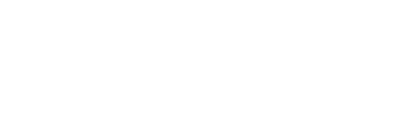Originariamente Scritto da
flag

un interessante punto di vista
che condivido
e che mi aspetto non sia assolutamente condiviso da molti amici, qui
20 dicembre 2013
La visione corta di chi la sa lunga
di Francesco Costa
Quando la crisi economica finirà – perché finirà, come sono finite tutte – e guarderemo a questi anni con uno sguardo un po' più distante, liberi di soffermarci con qualche lucidità in più sulle conseguenze laterali e culturali della crisi, sarà interessante ricostruire un fenomeno in particolare, che ha coinvolto il giornalismo e l'informazione. Forse ce lo racconteremo sorridendo, come un aneddoto divertente del passato, come oggi commentiamo certi video di vent'anni fa che riemergono di tanto in tanto su YouTube, e ci diremo: «Ma ti ricordi che razza di personaggi si vedevano in giro nei talk show, in quegli anni?».
Il grande spazio ottenuto giustamente dall'economia nell'informazione ha avuto infatti una conseguenza particolare in tv: ha dato visibilità a un nutrito battaglione di esperti o sedicenti tali, personaggi che la sanno lunghissima e che prosperano per via del contemporaneo calo verticale di credibilità dei politici e per il terreno fertile offerto da ogni crisi a chi dice cose "forti", e propone la tesi popolare e consolatoria per cui la colpa è soltanto dei politici – come se non li avessimo eletti noi, dal primo all'ultimo – oppure di un complotto internazionale tra banchieri, massoneria e cosiddetti "poteri forti".
L'economista che la sa più lunga di tutti è quello che mentre si discute faticosamente (e infruttuosamente: si chiamano talk show) di tasse, spesa o privatizzazioni, interviene ed esprime un concetto del genere con tono assertivo tra l'aggressivo e il catastrofico: voi non avete capito niente, nel migliore dei casi siete ignoranti, nel peggiore siete collusi col complotto internazionale. Per uscire dalla crisi basta fare una-cosa-molto-semplice.Quella cosa-molto-semplice sono tante cose, alcune ricorrenti, tutte discutibili e alcune decisamente comiche. La madre di tutte è l'uscita dall'euro. Liberarci una volta per tutte dal giogo dei vincoli di bilancio europei, ripristinare la sovranità monetaria, svalutare a più non posso e tornare così a correre felici su un campo di margherite che conduce verso la crescita, l'occupazione, la ripresa dei consumi, la prosperità. Al di là del fatto che l'Italia precedente all'entrata in vigore dell'euro è un ricordo abbastanza recente da permetterci di sapere che non era poi questo paradiso di ricchezza, la grandissima parte di chi ha studiato cosa comporterebbe l'uscita dall'euro descrive scenari molto diversi.
Anche sforzandosi di tralasciare tutti i modi in cui l'euro ha tenuto in piedi l'Italia – centinaia di miliardi di euro in interessi risparmiati, per dirne una tra tante – e occuparsi soltanto del meccanismo di uscita dalla moneta unica, è difficile prendere sul serio questa proposta. I fautori dell'uscita dall'euro sostengono che sarebbe sufficiente congelare per qualche tempo i movimenti di capitale per evitare disastri e corse agli sportelli: cambiare valuta nel weekend o a Capodanno. Il problema è che nell'ora X del passaggio tra le due valute forse non ci sarebbero più capitali da controllare, e questo perché non esiste ufficialmente una procedura per uscire dall'euro. Non vuol dire che sia impossibile farlo, a fronte dell'eventuale volontà politica, ma che servirebbe intavolare una lunga e complicata trattativa con gli altri Paesi dell'Eurozona. E le conseguenze dell'uscita dall'euro comincerebbero al momento dell'annuncio, non all'ora X. A meno di non voler chiudere le banche per settimane – se non addirittura per mesi – durante questa trattativa accadrebbe di tutto: fughe di capitali, prelievi di massa, banche collassate, tensioni per le strade, probabilmente una nuova terza recessione e non solo italiana.
La proposta di uscire dall'euro è spesso motivata col fatto che le regole del gioco siano truccate: che l'Italia non sia in difficoltà per i problemi storici del suo tessuto industriale e del suo mercato del lavoro, bensì perché la Germania bara e specula sulle difficoltà dell'Europa del Sud. Come se l'Italia non avesse un gigantesco problema di produttività, rispetto alla Germania, e bastasse stampare moneta per risolvere tutti i nostri problemi.
Questa logica "complottista" fa sì che la proposta di uscire dall'euro vada spesso di pari passo con un'altra tesi altrettanto radicale, tra gli economisti che la sanno lunga: l'Italia dovrebbe fare default. Dichiarare bancarotta, rifiutarsi di pagare tutto o in parte il proprio debito. Libera da questo fardello – come se ce l'avessero lasciato gli alieni, e non governi democraticamente eletti – l'Italia si ritroverebbe improvvisamente piena di risorse da spendere nel rilancio dell'occupazione e dei consumi. La proposta fila solo se ci si dimentica che nessuna delle economie cosiddette "avanzate" ha mai fatto default dopo la Germania nel 1948, che un gesto politico così estremo – a fronte dell'attuale solvibilità dell'Italia – metterebbe in discussione persino l'eventuale piccolo avanzo primario su cui potremmo contare, che da quel momento in poi sarebbe impossibile rivolgersi al mercato per finanziare la spesa e, soprattutto, che una grossa parte di creditori dell'Italia sono gli italiani stessi: chi ha investito in titoli di Stato, magari attraverso un fondo pensione, oppure le stesse banche da dove centinaia di migliaia di italiani cercherebbero di prelevare i propri soldi.
Alla base dell'idea di chi propone di fare default non c'è solo la convinzione che questo sia necessario per il bene del Paese, ma anche che sia un gesto eticamente giusto. È questo genere di sentimento che ispira una delle teorie più popolari tra i gruppetti complottisti di internet, anche questa recentemente emersa – e discussa come se fosse una cosa seria – nei talk show televisivi: quella del cosiddetto "debito detestabile". La tesi l'ha messa per iscritto nei primi anni del Novecento un oscuro giurista russo ed è stata applicata due o tre volte nella storia, in corrispondenza di guerre civili e invasioni militari: sostiene che quando un regime tirannico contrae un debito per rafforzare il suo potere e sopprimere un'insurrezione, e non invece per fare gli interessi della popolazione, un governo democratico che dovesse succedere al regime in questione potrebbe giudicare quel debito "odioso" e rifiutarsi di pagarlo. Secondo alcuni economisti da talk show l'Italia rientra in questa casistica. Sostengono che i governi italiani abbiano indebitato lo Stato senza che i cittadini ne fossero consapevoli e senza il loro consenso; che il denaro ottenuto in prestito non sia stato utilizzato per portare benefici alla società; che i creditori dell'Italia siano al corrente di questa situazione e se ne disinteressino. Un tribunale internazionale appositamente creato dovrebbe valutare l'esistenza di questi tre requisiti e stabilire quindi se l'Italia può rifiutarsi di pagare il debito. Peccato che non una di queste ragioni stia in piedi: il debito pubblico è frutto delle politiche di governi eletti lungo decenni in modo pienamente democratico; almeno parte di questo è evidentemente servito a pagare stipendi, pensioni, beni e servizi; i creditori sono almeno in parte i cittadini stessi, che non possono essere contemporaneamente oppressi e oppressori. Senza contare che l'Italia non è una tirannia né è stata appena conquistata dall'esercito di una potenza straniera.
Così come per dare credibilità all'assurda teoria del "debito detestabile" si dice che si tratta di uno strumento giuridico usato con successo in Messico nel 1883, a Cuba nel 1898 e in Iraq nel 2003 (ah beh, allora), molte altre teorie economiche spericolate vengono difese con l'argomento che all'estero «lo hanno già fatto» e «ha già funzionato». Ci sono soprattutto tre Paesi che vengono tirati in ballo e indicati continuamente come modello da quelli che la sanno lunga.
Il più antico è l'Argentina, che ha dichiarato bancarotta quando la sua economia è collassata nel 2001. «Sono ancora lì gli argentini, no?», dicono quelli che la sanno lunga. Si sono liberati della dipendenza dal dollaro, il loro Pil è cresciuto e la disoccupazione è scesa. Ci si dimentica che l'Argentina non fece default per una scelta etica bensì perché aveva drammaticamente finito i soldi, e non fu un bello spettacolo: le foto degli scaffali vuoti nei supermercati e delle rivolte dopo il congelamento dei conti correnti fecero il giro del mondo. L'Argentina da allora è considerata inaffidabile al punto che non può ricorrere al mercato per finanziare la spesa. Il governo è accusato di truccare i dati sull'inflazione per mascherare il fatto che questa sia cresciuta fino al 25 per cento, e l'inflazione – che agisce come una tassa spietata sui ceti medio-bassi – si deve probabilmente proprio alla necessità di finanziarsi stampando moneta. Senza i soldi di Cina e India, che sorressero le esportazioni con un fiume di denaro, le cose sarebbero andate persino peggio.
Altri citano allora l'Ecuador: un caso di default senza collasso dell'economia. Il presidente Rafael Correa nel 2008 annunciò che il Paese non avrebbe pagato il suo debito, definendolo «illegittimo», benché avesse i soldi per farlo. Peccato che l'Ecuador abbia ricomprato il 91 per cento del debito dai suoi creditori solo sei mesi dopo, per quanto a un terzo del suo valore, ma soprattutto peccato che quel debito fosse quasi cento volte più piccolo di quello italiano – e che l'Ecuador avesse allora un'economia basata per metà sulle esportazioni di petrolio, mentre il sistema italiano non può vantare tali risorse.
L'esempio che è circolato di più in questi anni, però, è quello dell'Islanda. Sì, uno Stato che ha meno abitanti di Palermo, che non ha l'euro e non fa nemmeno parte dell'Unione europea.
La storia viene descritta così: l'Islanda è uscita dalla crisi rifiutandosi di pagare il debito, ha scritto una nuova Costituzione grazie a internet e oggi è tornata a crescere (tutto ciò con un capo del governo donna, lesbica ed ex sindacalista, che nella narrazione del tutto aiuta molto). Se siete arrivati fin qui l'avete capito: non è andata così. La crisi in Islanda portò al fallimento delle tre grandi banche del Paese, che lo Stato decise di nazionalizzare. In piena recessione e con un debito pubblico esploso, l'Islanda fu salvata da un prestito del famigerato Fondo monetario internazionale, che erogò il denaro in cambio dell'adozione di una serie di misure di austerità. L'Islanda le mise in pratica con una certa diligenza e in breve tempo l'economia si rimise in moto.
A un certo punto gli elettori bocciarono due referendum sul fatto che fosse opportuno o no rimborsare un fondo pensione detenuto da una delle banche che lo Stato aveva nazionalizzato: da qui la leggenda metropolitana sul «non hanno pagato il debito». Non era il loro debito, quello che non hanno pagato, bensì i risparmi di 120mila cittadini inglesi e olandesi: sul momento furono coperti da Regno Unito e Paesi Bassi, nel frattempo una sentenza della Corte Suprema ha obbligato la banca fallita a ripagare la cifra. Intanto il Paese non può finanziarsi sui mercati internazionali, le misure di controllo dei capitali sono ancora in vigore, il progetto della nuova Costituzione è morto e sepolto. La premier donna e lesbica, che voleva fare entrare il Paese nell'Unione europea (pazza!), ha perso le elezioni. Le ha vinte il centrodestra, le cui politiche nel settore bancario avevano causato la crisi disastrosa del 2008 e la recessione. Questo è un pezzo della storia che quelli che la sanno lunga spesso dimenticano di raccontare, ma d'altra parte nei talk show il tempo per argomentare è poco, bisogna essere efficaci e concisi, dire le cose in fretta. E magari spararle grosse.
20 dicembre 2013